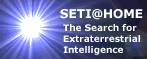Insomma, non sono così ottimista, sul futuro di questa proposta che, essendo stata presentata da Veltroni insieme col Prof. Salvatore Vassallo dell'Università di Bologna, è stata già da qualcuno ribattezzata "Vassallum".
Il sistema descritto da questa proposta dichiara come propri modelli ispiratori quello spagnolo e quello tedesco, perciò mi è venuto in mente, per spiegare come funziona, confrontare la Legge elettorale del Bundestag del 1956 con questo sistema.

1) Nel sistema tedesco gli elettori hanno due voti disponibili: Erststimme e Zweitstimme, il primo per eleggere un rappresentante nel proprio collegio uninominale e il secondo che verrà conteggiato su base federale (ma con un complesso sistema di ripartizione tra i Länder, secondo il sistema proporzionale. I due voti possono essere disgiunti.
1) Nel Vassallum gli elettori hanno solo un voto, ma con due valori distinti: da un lato il voto sarà contato per eleggere un rappresentante nel proprio collegio uninominale e il secondo che verrà conteggiato col sistema proporzionale non su base nazionale, ma in singole circoscrizioni che possono comprendere 6, 7 oppure 8 collegi uninominali.
2) Il numero dei seggi assegnati col sistema maggioritario è pari a metà del numero dei deputati. In Italia, l'art. 56 della Costituzione, però, fissa il numero preciso dei deputati in seicentrotrenta, senza possibili variazioni.
Il voto al maggioritario per un candidato è collegato ad una lista bloccata (tra l'altro graficamente posta sotto il candidato), perciò un voto maggioritario per il candidato locale del partito X al maggioritario sarà anche un voto al partito X al proporzionale nella circoscrizione a cui appartiene il collegio uninominale.
2) Il numero dei seggi assegnati col sistema maggioritario è pari a metà del numero dei deputati del Bundestag, che peraltro non è disciplinato a livello costituzionale (e questo è forse il motivo più semplice per cui il sistema in tedesco non può essere applicato integralmente in Italia per mezzo di una legge ordinaria), ma di cui è stabilito un "numero previsto" in base alla popolazione.
3) Al riparto proporzionale dei seggi partecipano tutti i partiti che hanno ottenuto almeno il 5% dei voti su base nazionale.
3) Al riparto proporzionale dei seggi partecipano tutti i partiti, senza sbarramenti rilevanti, perché il riparto stesso è compiuto non a livello nazionale, ma di circoscrizioni, che assegneranno soltanto 12, 14 o 16 seggi, dando meno possibilità ai partiti piccoli di entrare in Parlamento.
4) Il numero dei seggi assegnati col sistema proporzionale è uguale al "numero previsto" di tutti i deputati del Bundestag. A questo punto si ha già pressappoco un'idea della composizione del Bundestag, ma per ottenere la vera composizione dell'Assemblea bisogna ancora operare una sottrazione.
4) Anche col Vassallum si assegnano col sistema proporzionale tutti i seggi del Parlamento, e si deve dunque procedere ad una sottrazione, per determinare il numero definitivo dei deputati. A differenza del sistema tedesco, poi il Vassallum prevede un riparto proporzionale secondo il cosiddetto metodo D'Hondt.
5) Per questo si considerano tutte le liste che hanno ottenuto più del 5% delle preferenze col sistema proporzionale e più di 3 collegi uninominali, sottraendo i seggi ottenuti al maggioritario a quello ottenuto col sistema proporzionale.
Se una lista ha ottenuto più seggi al maggioritario di quanti le spetterebbero sol riparto proporzionale, li conserverà. Questi seggi in più, i cosiddetti Überhangmandate, saranno aggiunti al "numero previsto", dando così il numero e la composizione definitiva del Bundestag.
5) La sottrazione da operare, però, non avviene a livello nazionale, ma, come già dicevamo per il riparto proporzionale, a livello di circoscrizioni. Eventuali incongruenze tra il numero di seggi al maggioritario e di quelli al proporzionale vengono risolti eseguendo di nuovo la divisione proporzionale dei seggi (col metodo D'Hondt, si tratta semplicemente di selezionare meno seggi).
Il sistema, va detto, ha qualche pregio: cerca di inserire dei sistemi di limitazione alla frammentazione, riuscendo a non nominare mai parole come sbarramento, e riesce a conciliare in qualche modo sistemi noti per essere funzionali ed affidabili (il tedesco e lo spagnolo) con il nostro ordinamento.
D'altra parte, però, mi permetto di far notare una cosa che il sistema elettorale potrebbe e dovrebbe garantire: tutti i sistemi di limitazione della frammentazione dei partiti sono destinati all'insuccesso, se vengono aggirati dai partiti stessi, per mezzo di coalizioni. Una coalizione, in virtù dell'accordo elettorale che ne sta alla base, può organizzarsi per sfuggire alle regole di limitazione del sistema elettorale, permettendo anche a partiti molto piccoli di entrare alla Camera (col Mattarellum si applicò per esempio il sistema della desistenza, di cui wikipedia fornisce una spiegazione che secondo me non rende pienamente conto dei suoi effetti negativi).
Il vero problema, dunque, sono proprio le coalizioni predefinite che parte del nostro mondo politico vorrebbe conservare, per puntare ad un bipolarismo, senza pensare che queste coalizioni, permettendo a partiti piccoli di entrare in Parlamento, minano il tanto decantato bipolarismo prima che nasca davvero.
L'immagine viene da Wikipedia, ed è sottoposta alle condizioni dei file di Wikipedia.